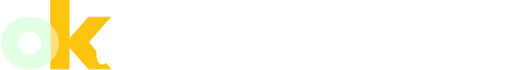Malattia, sofferenza, dolore. La scienza ci parla di virus, batteri, neoplasie. Tali concetti implicano un giudizio di ordine non solo biologico ma anche morale. Perché tra i tanti vizi di noi esseri umani c’è il voler dare significato a ogni cosa, soprattutto quando di male si parla. È da sempre uno degli interrogativi più dibattuti in ambito filosofico e anche teologico. A partire dalla Bibbia, il cui Antico Testamento associa le patologie al castigo di Dio per i peccati degli uomini. «Chi pecca contro il proprio creatore cade nelle mani del medico», si legge nel libro del Siracide. E ancora ai tempi odierni c’è chi, pure tra i sacerdoti cattolici, vede il coronavirus come una punizione divina. Come un segnale di avvertimento ai fedeli perché ritornino sulla retta via.
Il complesso di Bose
L’accostamento però stride con la figura evangelica di Gesù Cristo, che si rivela un medico, e non solo dell’anima. «… percorreva l’intera Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e proclamando la buona notizia del Regno e guarendo ogni malattia e infermità nel popolo», si legge nel Vangelo di Matteo. «Certo il Figlio di Dio non avrebbe curato persone che suo Padre aveva, invece, voluto punire», pensiamo mentre andiamo a caccia di una risposta tra i boschi e le vestigia medievali della Serra morenica di Ivrea. In una conca, sul territorio del Comune di Magnano (Biella), sorge il complesso di Bose.
Una comunità di monaci e monache laici, oggi un’ottantina. Appartengono a una chiesa cristiana fondata nel 1965 da un allora 22enne studente di economia e commercio, Enzo Bianchi. Oggi, di anni, padre Enzo ne ha 77, ha lasciato la carica di priore nel 2017 ed è una delle figure di spicco del dialogo ecumenico. Oltre a essere una delle voci più ascoltate del mondo religioso. A partire da tre papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco. E non solo.
L’origine del male
Padre Enzo, leggendo l’Antico e il Nuovo Testamento della Bibbia si resta un po’ spiazzati. Insomma, da chi proviene il male e, quindi, la malattia. Da Dio, dall’uomo o…?
«Per l’uomo è sempre stato un problema innanzitutto antropologico. Ancora oggi molti di noi, di fronte a una disgrazia o a una malattia, si chiedono: “Che cosa ho fatto di male?”. Nelle profondità dell’essere umano esiste un qualche meccanismo per cui il male richiama la colpa. E questo ha fatto sì che le religioni leggessero il male come un castigo di Dio per i peccati degli uomini. Di conseguenza la Bibbia stessa, come tanti altri testi dell’antichità, finisce per imputare malattia, sofferenza e disgrazia a un cattivo comportamento umano. Ma questo è terribile, perché comporta una duplice condanna della persona».
Poi, però, è arrivato Gesù…
«A dire che un comportamento umano colpevole non attirava da parte di Dio male e disgrazia era già stato qualche profeta dell’Antico Testamento, come Ezechiele. Ma è Gesù a compiere la vera rivoluzione. Innanzitutto condanna coloro che cercavano la colpa nei malati o nelle persone disgraziate. Quegli scribi e farisei che si interessavano più del peccato che della sofferenza. Per Cristo la sofferenza richiede soltanto un intervento di liberazione. Dal male, dalla malattia, dalla disgrazia. L’aver cancellato l’immagine perversa di Dio come colui che sanziona e punisce i peccati degli uomini è certamente una delle ragioni per cui è stato ucciso.
Tuttavia tale immagine è rimasta inculcata in profondità nelle religioni. E anche la Chiesa cattolica l’ha un po’ sublimata, sostenendo che malattia e dolore sono un’occasione di purificazione dai peccati e momenti in cui si acquistano meriti al cospetto di Dio. Una dimostrazione, purtroppo, di come le religioni siano ancora tante volte alienanti e non a favore ma contro l’uomo».
La responsabilità della Chiesa
Secondo il biblista – e suo amico – Alberto Maggi, frate dell’ordine dei Servi di Maria, «enorme è la responsabilità della Chiesa che, ignorando il messaggio evangelico, ha favorito la categoria veterotestamentaria della malattia come conseguenza del peccato. Per questo gradualmente la Chiesa ha abbandonato il Vangelo di Gesù e si è orientata sempre più verso la Legge di Mosè».
«Nella religione e nei movimenti spirituali vi sono correnti che vedono nel male e nella sofferenza un’opportunità di avvicinarsi a Dio. Quando invece noi sappiamo che il male e soprattutto la sofferenza fisica spesso abbruttiscono le persone. Dio non vuole la sofferenza umana e, se la volesse, sarebbe un Dio perverso. Da rifiutare e condannare. Molti santi, anche testimoni del nostro tempo come madre Teresa di Calcutta o il fondatore dell’Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer, vedevano nel dolore un’occasione di salvezza, purificazione e acquisto di meriti per la redenzione. Ma questo contraddice il messaggio di Gesù».
Se il dolore è associato a Gesù
Si racconta che proprio madre Teresa di Calcutta disse a un malato di cancro: «Stai soffrendo come Cristo in croce, di sicuro Gesù ti sta baciando». Il paziente le rispose: «Allora, per favore, digli di smettere di baciarmi».
«Queste espressioni, che possono sembrare di alta e raffinata mistica, in realtà sono scorciatoie che, togliendoci ogni responsabilità, addossano tutto a Dio. Così, ripeto, si dà un’immagine perversa di Dio. Un Dio siffatto va negato e i cristiani devono dire: “Questo non è il nostro Dio”».
Non conosciamo l’origine il male
Quindi, se «discolpiamo» Dio, è dall’uomo che proviene la malattia?
«No. Si racconta di un tempo aureo in cui non esistevano malattia e sofferenza. L’epoca del Paradiso terrestre, per la perdita del quale, pur di non dare la colpa a Dio, s’incolpò l’uomo. Adamo ha peccato e, di conseguenza, tutta l’umanità ne porta le conseguenze. No. Oggi la scienza ci dice che già prima che l’uomo apparisse sulla Terra esisteva il dolore tra le specie viventi e la vita era offesa da terremoti e cataclismi. In realtà non possediamo alcuna risposta alla domanda sulla provenienza del male».
Insomma, esiste e basta?
«Dove c’è la vita, là c’è la sofferenza. Dove c’è la vita, là c’è la malattia. Che non sia colpa né dell’uomo né di Dio ce ne stiamo rendendo conto in questi mesi con il coranavirus. È la stessa vita a essere fragile. Siamo precari, la terra è nostra madre, ci dà la vita e alla fine ci riaccoglie con la morte».
La visione olistica di Wojtyla
Giovanni Paolo II, in una lettera del 2005 al presidente della Pontificia Accademia per la Vita, evidenziò che «la salute non è un bene assoluto. Non lo è soprattutto quando viene intesa come semplice benessere fisico». Senza tenere conto della dimensione morale. Concorda con questa visione olistica?
«Sì e no. Indubbiamente la salute è il bene primario. Perché una vita minacciata costantemente dalla sofferenza spesso non è più vita. Se, come dice la Bibbia, c’è vita quando c’è relazione, esistono forme di malattia, come l’Alzheimer e le demenza senile, nelle quali la relazione con gli altri scompare. Tuttavia non dobbiamo pensare la salute come l’unico bene. Va combinata con la compassione, una parola che tocca tutti gli esseri umani, anche quelli dell’Oriente non cristiano. Compassione che molto spesso ha a che fare con la sofferenza e la malattia del prossimo. Pensiamo a chi perde la salute per curare altre persone o a chi è impegnato nella ricerca scientifica».
La malattia della madre
Lei ha avuto a che fare con la malattia fin dall’infanzia. Quando aveva solo otto anni, nel 1951, perse sua madre per stenosi mitralica, una patologia che ha iniziato a essere curata appena qualche mese dopo. Che cosa le ha lasciato questa esperienza tragica e beffarda al tempo stesso, che avrebbe allontanato molti da Dio?
«La vicina di casa, che portava lo stesso nome di mia madre, Angela, aveva la sua stessa malattia ed era in cura dai medesimi medici. Lei però non è scomparsa nel 1951, ma dieci anni fa. Era riuscita a sopravvivere fin tanto che hanno iniziato a operare la valvola mitralica. La morte di mia madre è stato un dolore grande, soprattutto perché ero figlio unico. Restavamo mio padre e io in un piccolo paese del Monferrato, Castel Boglione, soli senza alcun altro parente vicino.
È stato particolarmente difficile crescere in quel contesto portando il peso della condizione di orfano. Una ferita da cui non si guarisce mai. Ma mia madre mi ha lasciato un grande insegnamento. Da lei ho imparato a dire sì alla vita. Cosciente di dovere lasciarmi, si raccomandava con mio papà. Si raccomandava che mi facesse studiare e a me, che all’epoca avevo una salute molto fragile, diceva: “Guarda che tu devi assolutamente vivere. Io non ci sarò, ma la vita continua”».
La paura della morte
Ha detto di essere spaventato dalla morte. Un’idea che, però, contrasta con quella cristiana. Anche se è vero che sulla croce Gesù ha esclamato: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».
«È difficile dire il perché, ma fino ai 40 anni la morte non mi faceva alcuna paura. Da credente mi dicevo che alla fine sarei andato a vedere chi avevo tanto cercato. Prova ne è il mio libro “Vivere la morte”, un’antologia di cento racconti di morti, tra cui quella di mia mamma. Ma, appena varcati gli “anta”, mi è venuta una paura della morte che prima non conoscevo.
A 77 anni, man mano che le mie forze vengono meno o si presentano malattie, ormai faccio i calcoli. Non sono molti gli anni che mi stanno davanti e ho paura. Ma, appunto, anche Cristo ha avuto paura e non solo sulla croce. Il Vangelo di Luca ci dice che, nell’orto degli Ulivi, continuava a venire meno per lo sgomento che gli creava il pensiero della sua morte. Del resto ho visto morire in grande pace tanti che mi avevano confessato di avere paura della morte e, invece, andarsene disperate persone che sostenevano di non esserne toccate».
Il ruolo della fede
La fede aiuta?
«La fede mi sorregge. Però ho capito che la si misura soprattutto proprio quando si deve morire. Dall’altra parte troverò Dio? Il primo abbraccio che riceverò sarà quello di Cristo? Il dubbio viene, salvo poi essere vinto dall’amore. Le cinque persone che ho visto morire qui a Bose sono spirate con la loro mano nella mia, mentre dicevo loro: “Va’ in pace”. Spero che capiti anche a me, che quel giorno ci sia qualcuno che mi tenga la mano e mi dica di andare in pace. La cosa più terribile è morire soli. Avere qualcuno vicino dà la forza di credere che al di là non ci sia il nulla e che si possa riprendere qualcosa della nostra vita e dei nostri legami».
La morte oggi
Sempre a proposito di morte. Lei sul quotidiano la Repubblica ha scritto che «si è ormai smarrita la sapienza e la naturalezza con cui in passato si affrontava questa sfida». Che cosa intendeva?
«Da bambino vivevo di fronte alla chiesa. Quando qualche compaesano stava per morire, il parroco mi chiamava come chierichetto per assisterlo mentre andava a portare al sofferente la comunione e a dargli l’estrema unzione. In quelle morti contadine nel Monferrato c’era una naturalità che è andata persa, perché oggi la morte è diventata la manifestazione più pornografica in assoluto. I bambini attuali non hanno mai visto morire qualcuno. Anzi, a loro non si parla più della morte. Un’assurdità. La morte fa parte della nostra vita e prima o poi dobbiamo farci i conti. C’è la vita perché c’è anche la morte. Dovremmo impararlo non solo dal cristianesimo ma anche dall’eredità culturale dell’Antica Grecia, che abbiamo dimenticato ma che sarebbe importante per farci sentire l’appartenenza alla terra e all’umanità e non considerarci esenti dalla morte, in un delirio di onnipotenza che non ci dovrebbe appartenere».
Il testamento biologico…
Perché è favorevole al testamento biologico? È una posizione non condivisa da parte della Chiesa. Anche se papa Francesco sembra aver concesso un’apertura quando ha spiegato che bisogna trovare soluzioni anche normative il più possibile condivise. Tenendo «conto della diversità delle visioni del mondo, delle convinzioni etiche e delle appartenenze religiose, in un clima di reciproco ascolto e accoglienza».
«Un cristiano per la sua fede deve pensare che ha ricevuto la vita da Dio e a Dio può puntualmente restituirla. Ma dobbiamo anche riconoscere le ragioni di coloro che sostengono di non essere stati richiesti se avessero voluto venire al mondo e di avere il diritto, di fronte a certi contesti di sofferenza in cui la dignità non esiste più, di dire una parola sulla loro vita e sulla fine di essa. Non possiamo condannarli, perché ancora una volta si andrebbe a finire sull’espiazione del peccato senza vedere la sofferenza. Nei tempi passati la Chiesa mandava un cappellano ad assistere i condannati a morte. Perché, allora, non dobbiamo essere presenti, se da esse richiesti, anche accanto alle persone che decidono di mettere termine alla loro esistenza?».
… e l’accanimento terapeutico
Sempre Francesco in un messaggio alla Pontificia Accademia della Vita del 2017 si è espresso, in termini stavolta perentori, contro l’accanimento terapeutico. Lei che ne pensa?
«Negli anni ’70 del secolo scorso un mio grande amico ormai ultraottantenne, il patriarca Athenagoras di Costantinopoli, cadde a Istanbul rompendosi il femore. Volevano trasferirlo per le cure a Vienna, ma lui si oppose: “Non vale la pena, lasciatemi andare”. Si fece mettere l’eucarestia vicino al letto e morì da monaco. L’accanimento terapeutico non è umano, ma in Italia la mancanza di una cultura del dolore sovente fa sì che vi siano malati dalle terribili sofferenze che non vengono lasciati andare, quando, invece, basterebbe semplicemente una sedazione per lenire il loro dolore e accettare che la conseguenza possa essere una morte anticipata di qualche ora o giorno. A volte mi domando se tale mancanza non sia dovuta anche alla pesante eredità religiosa che dava al dolore un valore salvifico che in realtà non ha. Il mio compito è spegnere il dolore e la sofferenza là dove ci sono».
Quindi, padre Enzo, anche nel suo caso personale…
«Ho fatto testamento biologico. La decisione deve essere presa di concerto dal malato, dai parenti e dai medici e non lasciata a una singola categoria. Noi viviamo insieme e in qualche misura dobbiamo morire insieme, anche se l’atto della morte è sempre individuale».
La posizione sull’aborto
Leggiamo un suo intervento sulla rivista “Jesus”. «Nei miei scritti credo che la parola “aborto” non sia mai apparsa; in ogni caso non ho mai trattato di questa azione. Perché? Forse perché quand’ero piccolo mi si è detto che l’aborto era stato consigliato a mia madre». Quindi è d’accordo con Giovanni Paolo II, che, sempre nella citata lettera del 2005, si scagliava contro la salute riproduttiva, contro chi sostiene ragioni di salute nel rifiuto della vita nascente?
«A livello di embrione la scienza non può determinare niente. Non si tratta di parlare di omicidio, ma di dire che esiste un senso dentro di noi, che c’è una possibilità umana. Mia madre mi diceva sempre: “Tu ci sei perché io ti ho voluto e solo perché io ti ho voluto”. Io oggi ho 77 anni, mia mamma è morta a 30, non so se la mia nascita le abbia abbreviato la vita, ma di certo lei ha voluto che io vivessi. Che cosa era meglio? Non sta a me dirlo, però ho sentito tante volte donne di 70 o 80 anni ricordare l’aborto compiuto in gioventù come un qualcosa che riemerge interrogandole incessantemente. È una ferita aperta. Dobbiamo stare sempre molto attenti, bisogna ascoltare il dolore delle donne, che non è la stesso dell’uomo che deve diventare padre e neppure di chi deve giudicare dall’esterno».
La salute, bene individuale e comunitario
Le politiche sanitarie di vari Paesi, Italia compresa, rischiano un’intrusione nella vita del cittadini, pensiamo, per esempio, a provvedimenti contro tabagismo e alcolismo e a favore dei vaccini. È corretto considerare la salute un bene pubblico e non individuale?
«La salute è un bene individuale che però, siccome viviamo insieme, ci coinvolge tutti e quindi diventa un bene pubblico, comunitario. È sempre stato così, fin dall’antichità. Con il contratto sociale delle democrazie accettiamo che ci sia il diritto dello Stato di preservare la dimensione comunitaria della salute e non semplicemente quella individuale».
La figura del medico e la cristianità
Il medico come deve porsi di fronte all’etica cristiana? Può essere considerato il buon samaritano della parabola evangelica, cioè colui che si prende cura della totalità della persona?
«Anche quanto a cultura della malattia in Italia siamo ancora molto indietro, sovente i medici non hanno la consapevolezza di dover curare una persona e non solo la malattia di un organo, perché quest’ultima coinvolge l’intero corpo e la psiche. Mentre in Oriente la salute di un individuo dipende dal dietologo, dalla guida spirituale e dal medico, in Occidente siamo troppo biologisti e non abbiamo ancora imparato che esiste anche una dimensione psichica. Capisco che, visto come sono strutturati i nostri ospedali e l’elevato numero di pazienti che ospitano, per gli operatori sanitari non sia facile, ma molte volte sento pazienti che dicono: “Se solo il medico mi ascoltasse…”. L’epidemia più grave che oggi colpisce la nostra società è la mancanza di ascolto».
L’età della vecchiaia
Nei suoi libri, in particolare ne La vita e i giorni, ha trattato anche della vecchiaia, da vivere come un «compito e una sfida». Come affronta Padre Bianchi il naturale declino fisico e come cerca di rendere serena la sua terza età?
«Ho scoperto che, nonostante tutte le previsioni che si possano fare e per quanto ci si prepari, ci sono sempre sorprese, che aumentano con il passare del tempo assieme alla difficoltà di accettarle. Quattro o cinque anni fa mi sono accorto che stavo perdendo un po’ l’udito, poi ho scoperto di avere un glaucoma: sono due manifestazioni che non mi attendevo. Ultimamente, inoltre, ho avuto seri problemi a camminare per problemi alla spina dorsale, ernia al disco e, con ogni probabilità, calcificazioni ossee. Mi ha molto spaventato il fatto di percorrere cento metri in venti minuti e, quindi, di dovermi sedere per cinque minuti prima di poter ripartire, però poi da un lato pian piano lo si accetta e, dall’altro, ci si misura con ciò che invece si può fare in questa condizione.
Esami del sangue: la guida completa
E allora si scoprono altre possibilità. Per esempio, magari non posso più camminare per ore in città, ma il fatto di essere costretto a soste nei bar mi fa provare nuove esperienze, come l’ascoltare parlare le altre persone e vedere la gente che passa. Ho sempre sostenuto che la vecchiaia è una malattia, tuttavia occorre fare in modo di non chiudersi in se stessi e fuggire gli altri, ma continuare a trovare ragioni di vita e forme di comunicazione con il prossimo. Aggiungere vita ai giorni e non giorni alla vita, come scrivo nel mio ultimo libro».
A Bose vige la regola del silenzio, un valore perso dalla società attuale. Quali sono i suoi benefici?
«Bisogna sempre parlare di silenzi, al plurale, regola che vale anche per il termine solitudine. Ci sono silenzi negativi, che fanno molto male, come ci sono solitudini negative, che sono isolamenti, ma ci sono anche silenzi e solitudini feconde. Bisogna vedere il lato positivo tanto della solitudine, il cui bisogno si avverte di più da anziani ma che all’inizio può spaventare, quanto del silenzio, che occupa uno spazio temporale sempre maggiore, perché le altre persone ti parlano meno. Sono un’occasione per andare in profondità, per capire tante cose che si possono comprendere solo in questo modo».
Shalom, padre Enzo
Shalom in ebraico vuol dire pace. Ma, stando al salmo 38,4 («Non c’è shalom nelle mie ossa»), anche salute. I due concetti coincidono?
«Shalom in ebraico significa pienezza di vita, vita piena. Quindi, come recita il salmo, non c’è vita piena nelle mie ossa perché o la vita declina con la vecchiaia o ha fatto capolino la malattia o la mia non è più una situazione di espansione. C’è una grande ricchezza nella Bibbia, umanamente è il nostro grande codice, ma ci riporta costantemente a verità che vanno al di là delle formule e delle dottrine. È molto di più».
di Marco Ronchetto
Leggi anche…
None found